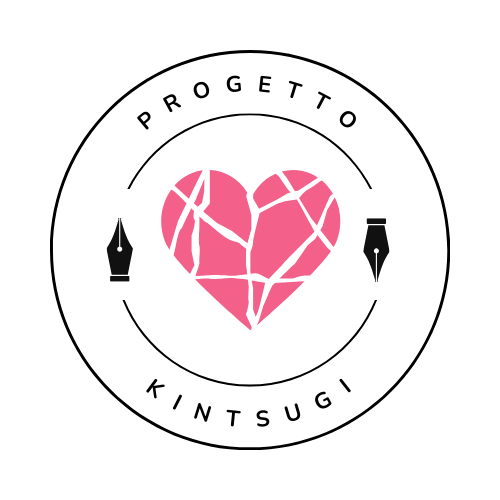Mi sono unita al popolo del port. Lo chiama così Severino Cesari nel suo bel diario, che mi sta accompagnando in queste settimane. Di unirmi al popolo del port, lo avevo deciso lo scorso 17 marzo, giorno di rottura di vene.
Ho scoperto il diario di Severino Cesari grazie ad Agnese, una lettrice del mio blog, la quale un giorno mi ha scritto un’email. Le sarò sempre grata, non solo per il suggerimento di lettura, ma anche per essersi fatta avanti: quando si scrive, è bello sapere di essere letti – non si scrive forse per questo, per essere letti? Lo diceva Eco [è tra le citazioni più saccheggiate della rete, mi associo allo scempio per difetto d’ingegno mio: «C’è una sola cosa che si scrive solo per se stesso, ed è la lista della spesa. Serve a ricordarti che cosa devi comperare, e quando hai comperato puoi distruggerla perché non serve a nessun altro. Ogni altra cosa che scrivi, la scrivi per dire qualcosa a qualcuno», Umberto Eco, Sulla letteratura, Bompiani, 2002].
Il Bat-apparecchio
Il giorno prima di andare in ospedale a mettere il port, ho letto questa pagina dal diario di Severino:
Se vi impiantano un port è come avere una presa elettrica sotto la pelle, predisposta per attaccare la spina ogni volta che volete. Attraverso la presa vi collegate a una macchina, appesa a un treppiede, che eroga e centellina le flebo che contengono l’energia elettrica, pardon i farmaci previsti dal protocollo della vostra terapia, che in questo modo arrivano all’organismo nel modo più efficiente e per lui meno dannoso.
Severino Cesari, Con molta cura. La vita, l’amore e la chemioterapia a km 0. Un diario 2015-2017, Einaudi 2021, pp. 184-185.
Un dispositivo biotecnologico che consente un accesso venoso centrale permanente.
Un catetere ad alta tecnologia, in sostanza.
Altro che le braccia blu e le vene rotte per i soliti aghi dei prelievi manuali, quando l’impianto non ce l’hai.
Sono molto orgoglioso del mio port.
È in effetti la cosa più simile a un Bat-apparecchio, un Bat-qualcosa che mi sia capitato.
Avevo molta paura, di mettere questo diavolo d’un port.
Questo, l’avere paura, mi stizziva. «Ho affrontato una mastectomia, – ho scritto agli amici, – mi hanno messo sottovuoto una tetta per settimane, faccio chemioterapie da due anni: non capisco perché sono così agitata per un port». «Forse è proprio perché arriva dopo tutte queste cose», mi ha risposto il mio amico custode. Lui con me fa sempre centro.
Sono irritabile, insofferente, esasperata.
Ecco cos’è. Io, questo ritorno del Granchio, non l’ho preso bene per niente. Nessuna forza, nessun coraggio, nessuna fiducia. Ė questo, credo, a cambiare le cose, le giornate, i risvegli e tutti i miei arrendevoli addormentamenti.
Mi scopro sprovvista di tutto, tutto, e soprattutto di pazienza.
E senza pazienza, il 16 aprile sono andata in ospedale a farmi impiantare il port, il mio Bat-apparecchio attraverso il quale, dalla prossima settimana, riceverò le terapie.
Ho dunque firmato l’ennesimo consenso informato sulle possibili complicanze dell’intervento (ematomi, infezioni, trombosi, occlusioni, stravasi) – il consenso informato ha questo compito qui, quello di generare pensieri spaventosi che fino a un momento prima non eri in grado nemmeno di concepire e, nonostante questo, farti firmare qualsiasi cosa pur di uscire dal posto in cui ti trovi e andare avanti, in qualunque modo, a un capitolo successivo di vita.
Anestesia locale, e un po’ di sedazione «per stare tranquilla», mi hanno detto mentre m’intontivano (volevano dire «mansueta», necessaria dote del paziente collaborante). Mi hanno allestito intorno al viso tutta una baracca di teli azzurri affinché la vista venisse coperta. La mente ha cercato allora un ricordo affine che fosse piacevole e ha trovato il capanno di tende e cuscini che io e mio fratello bambini costruivamo in camera. Ci riparavamo dal mondo, dagli adulti e, credo, dalla realtà.
Il chirurgo oncologico, un infermiere e un tecnico – tre uomini ad armeggiare su di me fra collo e petto, – si sono adoperati per entrarmi nella giugulare. Ci vuole fiducia, per offrire la giugulare a tre uomini in camice verde, ma la mia è ormai remissività soltanto. Ho sentito infilarci a forza un qualcosa, un ferro, un tubicino – era il catetere, – finché la sua estremità ha raggiunto la vena cava superiore.
Poi l’incisione al di sotto della clavicola: una tasca sottocutanea per alloggiare la camera del port, il piccolo serbatoio con il setto perforabile che a ogni terapia verrà punto con l’ago di Huber. Grazie a questo ago speciale, non-carotante, la membrana del serbatoio – ho imparato – può essere perforata fino a tremila volte prima di usurarsi. Puoi quindi ricevere fino a tremila somministrazioni, tremila farmaci, tremila terapie, tremila infusioni di aspettative.
A casa, mugolando per il dolore post-operatorio affrontato a colpi di tachipirina 1000 e scrosci di imprecazioni da far arrossire un eretico, chiederò all’intelligenza artificiale di dirmi tutto ciò che sa su questo genio di Huber:
L’ago di Huber si chiama così in onore di Peter Jost Huber, un matematico e statistico svizzero che ha sviluppato la funzione di Huber. Questa funzione, utilizzata in statistica e analisi della regressione, è nota per la sua sensibilità agli outlier, ed è anche utilizzata in metodi di regressione. Sebbene non sia direttamente connessa all’ago di Huber medicale, il nome dell’ago è spesso associato a Huber in virtù del suo lavoro nella statistica e nell’analisi della regressione.
Regressione?
L’unica regressione che mi è familiare è quella all’infanzia. La pratico sempre più assiduamente, in particolare nell’atto del piangere senza ritegno, nei capricci che faccio, nell’accudimento che pretendo da mia madre in fatto di nutrizione e faccende domestiche a casa mia (d’altra parte, a mia opinabile discolpa, assai lunga è la lista delle azioni vietate nelle prime due settimane di circolazione con il Bat-apparecchio: mi è stato interdetto anche l’uso del mocio).
I primi due giorni successivi all’intervento sono stati come credo siano stati, come credo possano essere, i primi due giorni fuori dal grembo materno. Non c’è nulla di più violento che venire al mondo.
Un promemoria per chi cammina, corre, o legge questo blog

Domenica 11 maggio, a Roma, ci sarà l’edizione 2025 di Race for the Cure di Susan G. Komen Italia.
La Race for the Cure è un evento a favore della ricerca sui tumori del seno, si svolge da 25 anni e raccoglie donazioni in Italia e nel mondo. Prevede una passeggiata di 2 km, oppure una corsa di 5 km aperta a tutti, oppure un percorso di 10 km riservato agli atleti competitivi.
Anche quest’anno, come l’anno scorso, partecipo alla passeggiata di 2 km e anche quest’anno ho creato la mia squadra, cioè un piccolo gruppo con cui camminare insieme, senza sforzo e senza gara.
Vieni?
Il gruppo ha il nome del blog e puoi unirti a questo link: raceforthecure.it//race/team/47/join/9606/CMFV97.
È possibile unirsi al gruppo anche senza poi partecipare personalmente all’evento a Roma – come hanno fatto pure quest’anno i miei amici Fabio e Cinzia da Milano (grazie!), come ha fatto Agnese dalla Romagna (grazie!). In questo caso, la tua partecipazione sarà la donazione alla Komen Italia: la donazione minima è di 25 euro e si riceve a casa un kit che include maglietta e zainetto (18 euro se si ritira personalmente il kit a Roma). Quella domenica mattina potrai comunque farti una passeggiata o una corsetta nella tua città indossando la maglietta.
Grazie.

[Immagine in copertina: Wallpaper BatMobile on GoodFon.com, licenza Creative Commons]