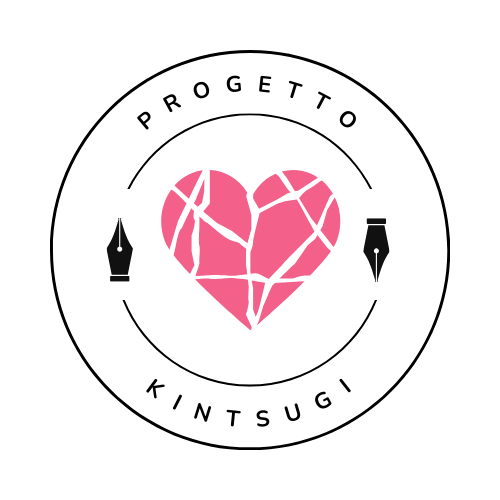Martedì 14 gennaio 2025. Sono nella sala d’attesa del centro medico dove, due anni fa, feci la mia prima esperienza di ago aspirato al seno. Allora non sapevo di avere un cancro, l’ipotesi si limitava a un sospetto da scongiurare. Era il 13 febbraio 2023, la mia vita aveva già iniziato a cambiare, debordare, rovesciarsi da ogni parte. Ho sempre questo problema con le date: le ricordo tutte.
Io mi ricordo.
Quell’ago fece male, non avevo esperienza di quel tipo di dolore, breve ma aguzzo. Il patologo non era di buonumore quel giorno, né tollerante verso la mia paura. Volevo guardare, non me lo permise. Volevo seguire con gli occhi l’attimo in cui l’ago avrebbe bucato la polpa del seno, per prepararmi, raccogliere coraggio. Invece lui mi schiacciò la testa contro il lettino e me la tenne ferma con una mano. L’esame prese tempo: il materiale biologico da prelevare richiedeva un’attenzione lenta, tutto un brutale rovistare nella carne della mammella destra. Piansi. Ma, bisogna dirlo, piansi di più nei mesi seguenti.
Con questo ricordo, oggi, torno a fare un ago aspirato allo stesso seno. Negli esami di controllo più recenti è stato avvistato qualcosa – un nodulo? Un linfonodo infiammato in seguito all’intervento? «Non possiamo assolutamente permetterci di rimanere con il dubbio», ha deliberato un mese fa il mio luminoso senologo milanese, il mio bel Gran Maestro russo, il mio Boleslavs’kyj de’ Navigli.
Eccomi, dunque, di nuovo qui. Sono cambiata da allora, tutto lo è.
Oggi non sento la stessa paura che avevo due anni fa, per almeno tre motivi.
Il primo è che l’intervento di mastectomia mi ha privato della sensibilità al seno e questo, adesso, è un vantaggio: per me, perché avrò una percezione ridotta del dolore; per il patologo, perché avrà tra le mani una paziente docile, niente piagnistei, nessun muscolo rigido.
Il secondo motivo è che in questi due anni sono diventata via via sempre più competente nell’uso preventivo di ansiolitici e calmanti, dosati con perizia rispetto a tempi e obiettivi: ho preso una compressa di Xanax dopo pranzo, seguita da dieci gocce di Valium verso le cinque e mezza del pomeriggio, poco prima di partire da casa. L’uno mi seda, l’altro mi rilassa la muscolatura. Sono calma, e anzi già sbadiglio, sono la fiera, placida e drogatissima regina delle benzodiazepine.
Il terzo motivo per cui la mia paura del dolore oggi è meno invasiva di allora è che sono passati due anni e, in mezzo, ci sono stati i dolori quelli seri, che fanno pregare di crepare subito. Sono meglio allenata. Diamoci una mossa, facciamo questa cosa.
Corpo, umano: «i corpi sono testi»
In sala d’attesa leggo una pagina dell’ultimo libro di Vittorio Lingiardi:
“Ci portiamo addosso cicatrici, stenosi, chiodi, placche, intarsi. Col passare del tempo i nostri corpi diventano esempi di kintsugi, frammenti saldati e non sempre con l’oro. Rita Charon, decana della medicina narrativa, ricorda come si potrebbe fare un’intera visita chiedendo a un paziente: ‘Mi parli delle sue cicatrici’. I corpi sono testi che tengono la traccia del passato, le cicatrici sono soggettività. Fisiche o mentali, possono gonfiarsi, indurirsi, riassorbirsi piano. Siamo noi”
Vittorio Lingiardi, Corpo, umano, Einaudi, 2024, p. 251
Ho citato Rita Charon in un vecchio post, quando il 26 luglio 2023 festeggiavo i miei primi cento giorni di chemio. Rita Charon ha scritto un libro che si chiama Medicina narrativa. Onorare le storie dei pazienti (traduzione di Christian Delorenzo, a cura di Micaela Castiglioni, Raffaello Cortina Editore, 2019). È in questo libro che mette a segno una frase di cui io mi sono appropriata: «È necessario raccontare il dolore per sottrarsi al suo dominio».
La medicina narrativa è addirittura un tag di ricerca in questo blog. Di cicatrici e di kintsugi, poi, sono due anni che blatero. Quindi, questa pagina di Vittorio Lingiardi ha molto senso per me. Per questo motivo mi sono portata dietro il suo libro – sono due anni che porto sempre con me qualche amuleto, in giro tra ospedali e ambulatori.
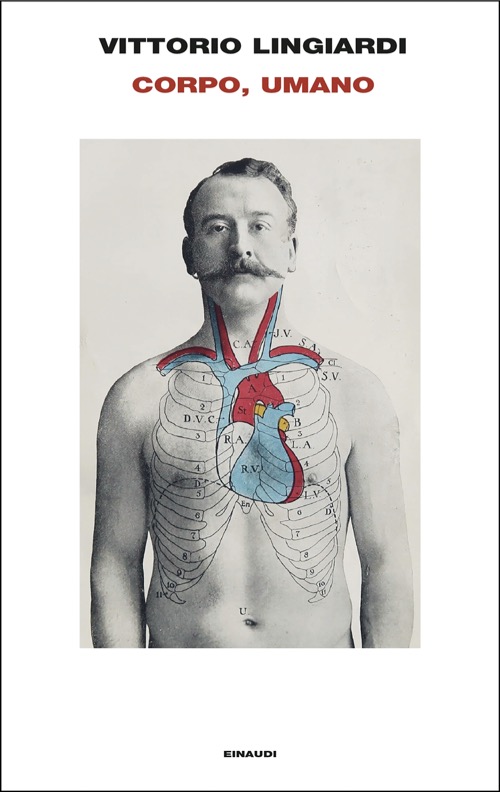
«Cara ragazza»
Così si rivolge a me, oggi, lo stesso patologo di due anni fa. «Cara ragazza», mi dice, dopo aver letto il riepilogo di tutta la mia storia clinica. Cara ragazza, mi dice, e mi aiuta con delicatezza a stendermi sul lettino. Incredibile, penso tra me e me, il rispetto che si guadagna dopo la miserabilità di un cancro; sbalorditiva è l’autorevolezza che si ottiene perfino al cospetto della scienza più austera, dopo essere arrivati vivi alla fine delle chemioterapie.
Ma la protesi: la protesi, dottore, è a rischio? Si può danneggiare? Toccherà correre a Milano a sostituirla? C’è questa possibilità, sì, ma noi saremo bravi, mi dice. Entreremo di taglio, perpendicolari alla cicatrice. Mi mostra come.
Non sento niente, no, nessun dolore
Appena un pizzico d’ape. Due pizzichi, anzi, perché i punti da bucare si rivelano due: due, cara ragazza, non uno, due sono i linfonodi, o i nodulini che dobbiamo esaminare. Come mai ecografia, risonanza e PET non li hanno visti entrambi? Quante cose ho in giro per il corpo di cui non so, non sappiamo ancora?
Comunque, stavolta nemmeno una goccia di sangue. Il mio seno malato, curato, tagliato, violato, svuotato, ricucito, oggi pare scolpito in un marmo appena screziato di venature dal rosa al prugna.
«Seno è un nome bellissimo»
Il terzo degli organi dettagliati nel saggio di Vittorio Lingiardi è il seno, che secondo lui è un nome bellissimo. Il sinus latino, ci dice, indica un elemento concavo, una sinuosità nascosta. E anche: cuore di un luogo, rifugio, grembo, baia, tratto di mare, spira del serpente, cavità di una struttura ossea, seni di Valsalva, seno e coseno nella trigonometria. Quante cose è, il seno.
Il greco mastos, prosegue Lingiardi, lo abbiamo lasciato al linguaggio medico. E infatti: mastectomia è la parola che mi riguarda.
E le parole del dialetto, poi? Minne, pocce, bocce, poppe, sise, tette, zinne, zizze. A proposito di sise, suggerisco un’integrazione al testo di Lingiardi: nel chietino, non molto lontano da me, si mangiano le Sise delle Monache, un famoso dolce tutto protuberanze di pan di spagna e crema. Sono buonissime, morbide e per nulla castigate, oggi annoverate fra i prodotti agroalimentari tradizionali abruzzesi. Mentre faccio ricerche per scrivere questo post, scopro che anche in Sicilia si mangiano le Minne di Sant’Agata: cassatelle a forma di tettina.
Mutilati e martiri sono i seni delle sante, Agata ne è la protettrice, torturata a Catania nel 251 durante le persecuzioni sotto l’imperatore Decio.

Mutilate sono anche le mammelle delle pazienti oncologiche operate al seno.
Il tumore al seno, e la vergogna di Atossa
La prima malata di tumore al seno di cui sappiamo, grazie a Erodoto, è la principessa persiana Atossa, figlia di Ciro il Grande, vissuta tra il VI e il V secolo a. C. Pare proprio sia il primo caso registrato nella storia del tumore al seno. Atossa abbandonò la corte e si isolò per la vergogna.
La vergogna, da allora, arriva fino agli anni Cinquanta, quando The New York Times rifiuta di pubblicare un annuncio a pagamento di un gruppo di sostegno per donne malate di cancro al seno: «cancro» e «seno», negli anni del boom, sono parole impubblicabili. Oggi per i giornali non lo sono più, ma la vergogna, per molte donne, è rimasta. Non per le mie donne-albero, che il loro cancro al seno lo raccontano.
Aspettare
Le pagine di Vittorio Lingiardi oggi mi fanno compagnia, mi proteggono, mi difendono, mi aiutano. I libri mi hanno sempre aiutato a sopportare la vita.
Adesso, dopo questo solletico di ago aspirato, aspetto. Aspettare è quello che un paziente oncologico fa più spesso: aspettare in una sala d’attesa per sottoporsi a un esame o una visita; aspettare un referto, due, tre, dieci; aspettare il parere dei medici; aspettare una risposta; aspettare la data di un intervento chirurgico; aspettare i benefici di una terapia, e i suoi effetti collaterali; aspettare la guarigione; aspettare i controlli successivi alla guarigione.
Aspettare che la storia finisca.
[Credits: l'immagine in copertina è Olympia, il dipinto di Édouard Manet del 1863, fonte: Wikipedia. È una delle immagini scelte da Vittorio Lingiardi nel suo citato e saccheggiato Corpo, umano, proprio nel capitolo dedicato al seno, pag. 68]
Colonna sonora per questa lettura: Lascia ch’io pianga del Rinaldo di Händel, che, cantata da Sara Mingardo, fa piangere anche Lingiardi (a pagina 75 del suo libro, immancabilmente nel capitolo dedicato agli occhi).