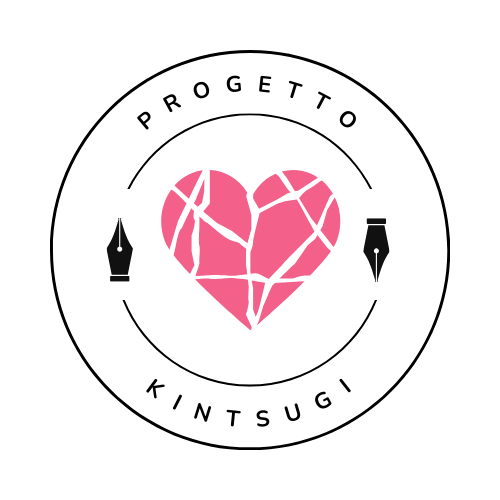Lunedì 17 marzo 2025. Ciclo 1-B, giorno 8. Il “richiamino”
Gemcitabina 1700 mg, carboplatino 200 mg (1, 8-21). Preparazione: antiemetico, gastroprotettore, corticosteroide (Akinzeo, Pantorc, Soldesam).
La terapia di oggi è un richiamo di quella fatta lunedì scorso. Non c’è l’immunoterapico Pembrolizumab, per il resto è pressoché uguale anche nei dosaggi ed è la seconda parte, una specie di rinforzo (“richiamino”, in gergo di corsia), di un ciclo completo che dura ventuno giorni. Dopo oggi, quindi, avrò due settimane di riposo prima di iniziare il secondo ciclo.
Prima del richiamino, però, stamattina prelievo. Il prelievo prima di iniettare altri farmaci citossici è d’obbligo ed è un momento importante nella routine del paziente oncologico: globuli bianchi, globuli rossi, piastrine, bisogna vedere fino a quale limite si può ancora spingere il corpo. Si fa di solito il giorno prima della terapia, al massimo due, ma questa volta io faccio tutto nello stesso giorno.
«Quando lo mettiamo, il Port?».
Me lo chiede Loredana, l’infermiera di turno stamattina ai prelievi, mentre mi tamburella il braccio alla ricerca della vena. Ci sto pensando, le dico.
«Eh no, – non si arrende Loredana, – perché qua a furia di bucare diventa uno strazio, lo sai, e buca per il prelievo, e buca per la terapia, le tue vene poi sono ancora stanche dell’altra volta». Si riferisce alle chemio del 2023, alla mia prima volta nel mondo dei pazienti oncologici. Per i primi due o tre mesi di terapie ho portato il PICC al braccio sinistro, poi abbiamo dovuto toglierlo per un loop che mi metteva a rischio di trombosi, e abbiamo continuato bucherellando dove si poteva.
Il PICC non si può rimettere. Il braccio destro non si può usare, per via della linfoadenectomia dell’anno scorso che lo ha reso poco collaborativo in diverse operazioni, compreso il sollevamento di pesi nemmeno importanti. Rimane il braccio sinistro, solo quello, fino alla mano. E le mie vene non sono più le buone di un tempo. Quindi quando lo mettiamo, il Port? Così almeno buchiamo solo per i prelievi. Sì perché, per i prelievi, il Port è preferibile usarlo il meno possibile e farci passare solo i farmaci delle terapie.
Nel diario di Severino Cesari che sto leggendo c’è un capitolo che si intitola “Il popolo del port va a fare un normale prelievo, e riesce”.
Anche Severino Cesari aveva il Port sottocutaneo nella succlavia, per le terapie. Ai prelievi invece sperava sempre ci fosse Miss Universo, l’infermiera col tocco speciale per il prelievo perché prendeva la vena al primo colpo («Al peggio, al secondo»).
«Lei, come sa bene, ha le vene difficili, bisogna andarsele a cercare, si nascondono dappertutto, poi sono molto logorate dall’uso, – constatò un giorno il Maestro di Miss Universo, l’ispirato e magrissimo dottor Zotti. – Si rompono, se non c’è l’arte. È risaputo. Usi mattina e sera Android 40 000 U.I. Android fa bene alle vene. Mattina e sera, sulla vena da usare», e fece il gesto di spalmare la marmellata sul pane, avanti e indietro. Non ci crederete, ma quasi tutte le volte che non uso Android la vena si rompe. Se poi non ci sono Miss Universo o il Maestro, che viene sempre più di rado, è proprio certo. «Si rompe la vena, e con le vene che lei ha, poi diventa una caccia al tesoro», aveva detto a suo tempo Zotti, e continuava a battere piccoli colpetti con le dita per farle emergere, le benedette. Io sì, lo sapevo bene, che senza l’arte si rompono […].
Severino Cesari, Con molta cura. La vita, l’amore e la chemioterapia a chilometro zero. Un diario 2015-2017, Einaudi, 2021, pp. 42-43
Le vene, senza l’arte si rompono.
Al mio prelievo, tutto bene. Qualche ora più tardi, alla terapia, scopro che male fa una vena quando si rompe. «Ecco, l’avevo detto», strilla Loredana tutta smagata d’animo. E pensare che lei, come la Miss Universo di Cesari, l’arte ce l’ha. Tutte qui ce l’hanno. Bisogna avercela, l’arte, per lavorare come infermiera a oncologia.
Mi s’è rotta la vena, dunque. «E adesso chi me la ripaga?» dico ridacchiando per sdrammatizzare e far divertire Loredana che ha cambiato sguardo e colore.
Arrivano Anthea, Marqueta, Veronica, che succede, che succede. «Niente, non trovo niente nel braccio! – dice Loredana, che ormai l’ha presa sul personale, – Devo cercare nella mano, Annalisa, mi dispiace». E che sarà mai, buca ‘sta mano. La mano è più collaborativa, la vena si trova e questa terapia oggi si può iniziare. Ché comincio a scocciarmi.
Quanto fa male la gemcitabina quando inizia a scorrere in vena, da qualunque parte si prenda. È un dolore denso che riempie mano, polso, braccio, si propaga e vibra. Come già la settimana scorsa, rallentano la velocità di infusione, ma di poco, perché la gemcitabina, l’ho già detto, va iniettata nell’arco di trenta minuti.
Mi concentro sui colori del cielo che vedo oltre la finestra – scelgo sempre un letto vicino alla finestra, se libero. Oggi è carta da zucchero, il colore del cielo. Infilo gli auricolari, metto i Sigur Rós, Fjögur píanó, e aspetto il sonno che, lo so, arriva profondo con il carboplatino.
Oggi papà compie gli anni.
Ne fa settantuno, di cui quarantatré di paternità critica – quarantaquattro quest’anno, a settembre («se Dio vuole» come si dice tra chi crede. Qualcuno dovrà pur volerlo). Glieli faccio festeggiare qui in reparto, dove oggi mi ha accompagnato a fare le terapie. Proprio oggi che mi si è rotta la vena, mannaggia; lui è sensibile per queste cose, infatti non ha potuto sopportare la scena e si è allontanato dalla stanza. Da un po’ di tempo lo vedo disorientato, papà. Chissà com’era, la vecchiaia che si era immaginato.
Per questo secondo cancro, stavolta in reparto ho firmato un foglio dove dichiaro che le informazioni sul mio stato di salute e sull’evoluzione della malattia vanno date a me soltanto. Ci penso io a filtrare. Se, per esempio, tra qualche mese gli esami di controllo rivelassero questo: che le nuove terapie sono inefficaci, che il Granchio continua a colonizzarmi ostinato e capillare, che il mio tempo a disposizione s’accorcia, – se rivelassero questo, dico, lo saprei io sola, nessun delegato, nemmeno mio fratello, che già avrebbe il suo bel da fare, povero cristo, come fiduciario del mio testamento biologico.
Anche perché, ancora a proposito di quel povero cristo di mio fratello fiduciario e di tutti i suoi pensieri, quest’anno nella nostra famiglia ci sarà una nuova nascita da festeggiare: quella del mio secondo nipote. Nascerà a settembre («se Dio vuole»), mese del mio compleanno. Una zia morente in famiglia ci vuole, e questo lo vuole il plot narrativo. L’umorismo nero che mi permea l’immaginazione non ha potuto fare a meno di farmi figurare scenari di fine estate in cui la morte e la vita si passano il testimone nella luce gialla del tramonto. In famiglia queste cose non le vogliono sentire, mancano di senso dell’ironia e vita interiore; solo a mio padre l’ho detto perché è da lui che ho preso il gusto crepuscolare, e lui ha annuito e commentato: «Ci avrei giurato che avevi pensato una delle cazzate tue». Quanto prezioso materiale per una sceneggiatura, un romanzo, uno spettacolo teatrale che non sarò io a scrivere.
«Mettiamo questo cazzo di Port», dico alla fine della terapia di oggi.
Tutte contente tranne me arresa: le infermiere, l’oncologa. Mi mandano dall’impiantatore di Port a organizzare l’intervento. Lo impiantano solo ogni terzo mercoledì del mese, mi spiega, quindi questo mese la data sarebbe dopodomani, mercoledì 19 marzo, ma è già tutto prenotato, posti esauriti.
È numeroso, il popolo del Port. La prossima data disponibile per l’impianto è mercoledì 16 aprile, toccherà quindi fare un altro ciclo di terapia cercando vene e rompendone almeno un’altra. Va bene.
Torno a casa sfinita, svenata, irrorata di veleni, rimetto i Sigur Rós e riprendo il sonno da dove l’avevo lasciato, immobile, insensibile a ogni stimolo esterno, in uno stato di morte apparente che in questo momento è quasi una benedizione.
[Immagine in copertina: pin.it/m9AJhJep3]